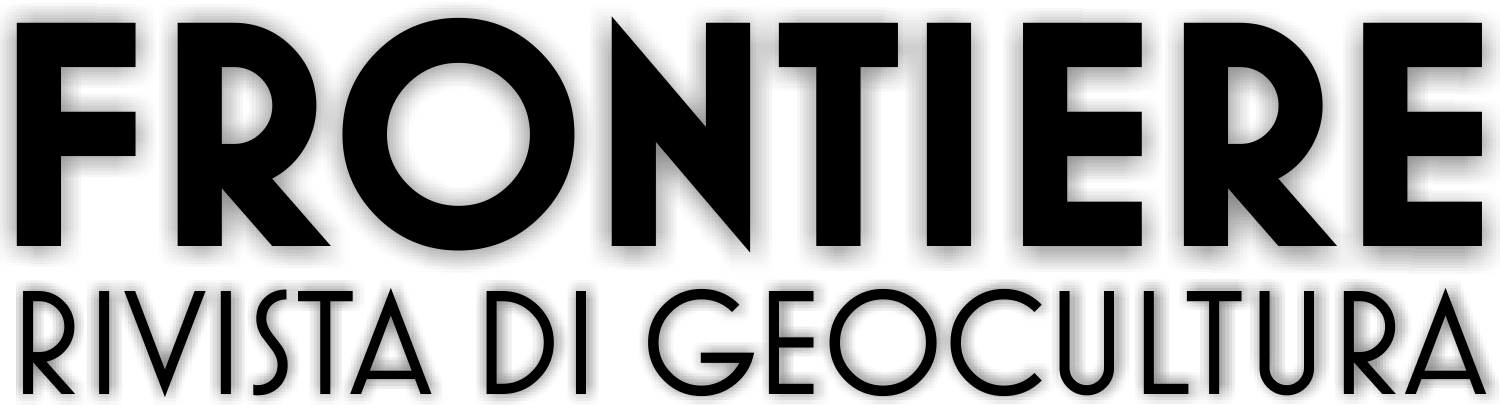di Galliano Mari Speri
Il 17 aprile, l’edizione internazionale dell’autorevole quotidiano tedesco Handelsblatt ha reso pubblica l’esistenza di un documento firmato da 27 ambasciatori dell’Unione Europea (con l’eccezione dell’Ungheria) che esprimeva forti perplessità sul progetto cinese denominato Belt and Road Initiative (BRI) e conosciuto anche come Nuova via della seta, che ha lo scopo di creare un blocco commerciale integrato tra Cina, Africa e Europa. I diplomatici hanno messo nero su bianco che il progetto di Pechino “si prefigge obiettivi politici domestici come la riduzione del surplus di capacità produttiva, la creazione di nuovi mercati di esportazione e la salvaguardia dell’accesso alle materie prime”, aggiungendo che “non dovremmo rifiutare di cooperare ma dovremmo educatamente eppure fermamente affermare le nostre condizioni”. I cinesi hanno risposto in modo molto seccato ma è inoppugnabile che il documento tocca un punto cruciale per gli sviluppi strategici dei prossimi decenni.
Il progetto cinese intende espandere le vie marittime e le infrastrutture terrestri che dalla Cina toccano l’Asia, l’Africa e l’Europa, contribuendo allo sviluppo del commercio e della crescita economia mondiale. Il piano, il cui nome fu coniato dal presidente cinese Xi Jinping nel 2013, si ispira al concetto di Via della seta, nata 2000 anni fa sotto la dinastia Han, e intende sradicare la povertà, creare nuovi posti di lavoro, affrontare le conseguenze della crisi finanziaria internazionale, promuovere lo sviluppo sostenibile e favorire la creazione di un’economia di mercato avanzata e la diversificazione economica. Si tratta di un progetto a lungo termine che darà alla Cina un ruolo guida a livello culturale, economico, politico e commerciale. L’iniziativa BRI ha dimensioni colossali perché coinvolge quasi 70 Paesi con una popolazione di 4,8 miliardi di persone, le cui economie assommano a 21 trilioni di dollari (circa il 62% del PIL mondiale) e prevede investimenti per quasi mille miliardi di dollari. Tutti sanno che la Cina è la seconda potenza economica mondiale, ma pochi sono informati che insieme all’aggressiva espansione commerciale (prodotti a basso costo e dumping che non rispetta alcuna regola) è stata messa in campo una sofisticata strategia di soft power, che mette in primo piano il cinema e la cultura cinese. Il 14 maggio si è svolta a Pisa l’undicesima edizione del Chinese Bridge (Ponte cinese), organizzata dall’ambasciata cinese in collaborazione con l’Istituto Confucio di Pisa, con la partecipazione di studenti delle scuole superiori italiane e di San Marino, che si sono sfidati in una prova di conoscenza della cultura e della lingua cinese. I due vincitori parteciperanno alla competizione mondiale 2018 e rappresenteranno l’Italia in Cina. Non ci dovremo sorprendere se nei prossimi anni spunteranno nelle nostre città tanti “Istituti Confucio” che avranno la funzione di far conoscere la storia e la cultura cinese, in linea con la crescente influenza economica che Pechino ha in Italia.
BRI e Piano Marshall Un progetto di investimenti così mastodontico può essere paragonato per dimensioni al Piano Marshall, l’iniziativa del governo degli Stati Uniti che nel secondo dopoguerra investì 14 miliardi di dollari (del tempo) per quattro anni nell’Europa distrutta, rimettendo in moto l’economia e creando le precondizioni per lo sviluppo democratico del continente, diventato oggi l’area economica più prospera del mondo e con strutture di assistenza sociale che non hanno paragone. Gli USA non fecero distinzione tra Paesi alleati o sconfitti in quanto le finalità dell’operazione non erano soltanto economiche ma anche politico-sociali, poiché si trattava di far trionfare la democrazia e imporre una concezione liberale dell’economia. [caption id="attachment_10658" align="aligncenter" width="440"] Il Segretario di Stato statunitense, il generale George Marshall, diede il nome al piano omonimo che ebbe un ruolo centrale nella ricostruzione dell’Europa dopo le distruzioni della Seconda guerra mondiale.[/caption]
Quella strategia si è poi rivelata lungimirante e ha regalato all’Europa lunghi decenni di pace e stabilità politica che si è poi tradotta in prosperità economica. Tutto ciò fu però possibile perché gli USA erano un Paese democratico, con una stampa libera e un sistema di governo trasparente. Non si vuole qui mettere in dubbio l’importanza fondamentale degli scambi commerciali, che contribuiscono non solo allo sviluppo economico ma a quella conoscenza reciproca che è il miglior antidoto ai conflitti. Il problema vero è l’assenza di reciprocità, la mancanza di trasparenza e il rispetto di riconosciute regole internazionali da parte cinese. Il fatto è che l’Europa tratta da una posizione di debolezza a causa dell’assenza di una visione unitaria che gioca a favore della strategia cinese del divide et impera. L’Ungheria, retta dall’autoritario Victor Orban, dipende pesantemente dagli investimenti cinesi e non è certo casuale che il suo ambasciatore non abbia firmato il documento europeo. Anche la Grecia è in una posizione di grande difficoltà, poiché la sua più importante infrastruttura marittima, il porto del Pireo, è di proprietà di una multinazionale cinese che si trova quindi in una posizione strategica dominante all’interno del Mediterraneo. L’agenzia Bloomberg ha pubblicato da poco un rapporto secondo il quale negli ultimi dieci anni le imprese cinesi, sia pubbliche che private, hanno investito in Europa 318 miliardi di dollari in 678 operazioni (completate o in via di completamento), molto più di quanto è stato investito negli Stati Uniti. In Italia la Cina ha fatto 85 operazioni per un controvalore di 31 miliardi di dollari, che includono il gruppo Pirelli, Ansaldo Energia, Snam e Terna, Ferretti Yacht, Krizia, Olio Sagra più molte altre entità minori.
Vorrei ricordare soltanto due episodi, piccoli ma indicativi della difficoltà con la quale la Cina segue le regole rispettate da tutti gli altri. Qualche anno fa un gruppo di vigili si recò nella zona di via Paolo Sarpi, considerata la Chinatown milanese, per far rispettare gli orari di carico e scarico merci degli esercenti locali. I commercianti cinesi non solo si ribellarono alle legittime richieste dei vigili, ma scesero in strada con grandi bandiere cinesi e le sventolarono come per denunciare un’aggressione ingiusta e razzista nei loro confronti. Il governo di Pechino intervenne e fece pressioni su quello italiano e l’operazione venne bloccata. In un altro caso, un importante produttore italiano di rubinetteria si ritrovò a una fiera internazionale affiancato da una ditta cinese che esponeva l’intera gamma dei suoi prodotti, copiati minuziosamente da quelli italiani e, ovviamente, a prezzi stracciati.
Scambi commerciali e reciprocità
Il rispetto della proprietà intellettuale è un concetto molto difficile da far accettare alla Cina che, da un lato ha sviluppato settori tecnologicamente avanzati facendo investimenti enormi, ma dall’altro, continua imperterrita a copiare qualunque prodotto che la interessi. La situazione è diventata tanto seria che Cecilia Malström, la commissaria europea alla concorrenza, ha annunciato un ricorso all’Organizzazione mondiale del commercio per le continue violazioni cinesi. Un problema aggiuntivo è che invece di creare un fronte comune per costringere la Cina a rispettare le regole internazionali, il presidente americano Trump ha iniziato una disastrosa politica unilaterale di imposizione di dazi che contribuisce oggettivamente ad indebolire l’Europa. La questione vera è che, come ha affermato un diplomatico anonimo citato da Handelsblatt, i cinesi ascoltano con attenzione e cortesia le lamentele ma continuano tranquillamente a mettere in pratica una strategia commerciale scorretta. Negli ultimi anni, gli investimenti cinesi all’estero sono cresciuti in modo esponenziale ma l’inverso non è possibile perché se un’impresa occidentale vuole investire in Cina deve cedere la propria tecnologia al produttore locale. In questo modo l’economia cinese riesce ad acquisire un know-how enorme senza costi di infrastrutture e ricerca e senza alcuna penalizzazione sui propri investimenti in Occidente. Inoltre, Pechino applica sui prodotti di importazione tariffe che sono spesso il doppio di quelle occidentali e non esita a servirsi di barriere non tariffarie come l’ambiente o la sanità per limitare l’import.
Lo scorso febbraio il GTAI, l’ente tedesco per il commercio estero, in collaborazione con l’Associazione delle camere di commercio tedesche, ha pubblicato uno studio in cui si afferma che il progetto BRI sta puntando su Paesi politicamente instabili e con una cornice legale incerta. Finora l’80% dei progetti finanziati dalle banche di Pechino sono andati a imprese cinesi e la regolamentazione per l’assegnazione degli appalti non è assolutamente trasparente per cui questo rimane un aspetto da chiarire assolutamente. Handelsblatt riferisce che lo scorso maggio una delegazione dell’Unione Europea, di cui faceva parte l’ex ministro dell’Economia tedesco Brigitte Zypres, si è recata a Pechino per lanciare in pompa magna la Nuova via della seta e firmare una dichiarazione congiunta. La delegazione europea ha richiesto una riformulazione del testo che avrebbe dovuto garantire “uguali opportunità per tutti gli investitori nelle infrastrutture dei trasporti”. I cinesi hanno rifiutato ogni cambiamento e il documento congiunto non è stato firmato. In un discorso, tenuto a metà aprile scorso, il presidente Xi Jinping ha affermato che la Nuova via della seta “non è una cospirazione cinese come qualcuno all’estero sta affermando”. La Cina, ha continuato, non ha intenzione di mettere in campo “giochi geopolitici che facciano solo i nostri interessi”. Se le cose stanno così, è il caso che Pechino risponda alle domande e alle perplessità finora formulate.
La grande espansione militare cinese
L’idea di una poderosa espansione dei commerci e delle infrastrutture mondiali è certamente positiva e lodevole. Il problema è che questa iniziativa è associata a un massiccio aumento degli investimenti militari e a una espansione senza precedenti della marina militare cinese che, de facto e senza rispettare la legge internazionale, sta trasformando l’enorme braccio di mare tra la Cina e l’Indonesia in una vero e proprio mare cinese. Il nome geografico di quell’area è Mar cinese meridionale ma comprende le acque territoriali di Taiwan, Filippine, Vietnam, Malesia e Indonesia.
[caption id="attachment_10659" align="aligncenter" width="450"]
Il Segretario di Stato statunitense, il generale George Marshall, diede il nome al piano omonimo che ebbe un ruolo centrale nella ricostruzione dell’Europa dopo le distruzioni della Seconda guerra mondiale.[/caption]
Quella strategia si è poi rivelata lungimirante e ha regalato all’Europa lunghi decenni di pace e stabilità politica che si è poi tradotta in prosperità economica. Tutto ciò fu però possibile perché gli USA erano un Paese democratico, con una stampa libera e un sistema di governo trasparente. Non si vuole qui mettere in dubbio l’importanza fondamentale degli scambi commerciali, che contribuiscono non solo allo sviluppo economico ma a quella conoscenza reciproca che è il miglior antidoto ai conflitti. Il problema vero è l’assenza di reciprocità, la mancanza di trasparenza e il rispetto di riconosciute regole internazionali da parte cinese. Il fatto è che l’Europa tratta da una posizione di debolezza a causa dell’assenza di una visione unitaria che gioca a favore della strategia cinese del divide et impera. L’Ungheria, retta dall’autoritario Victor Orban, dipende pesantemente dagli investimenti cinesi e non è certo casuale che il suo ambasciatore non abbia firmato il documento europeo. Anche la Grecia è in una posizione di grande difficoltà, poiché la sua più importante infrastruttura marittima, il porto del Pireo, è di proprietà di una multinazionale cinese che si trova quindi in una posizione strategica dominante all’interno del Mediterraneo. L’agenzia Bloomberg ha pubblicato da poco un rapporto secondo il quale negli ultimi dieci anni le imprese cinesi, sia pubbliche che private, hanno investito in Europa 318 miliardi di dollari in 678 operazioni (completate o in via di completamento), molto più di quanto è stato investito negli Stati Uniti. In Italia la Cina ha fatto 85 operazioni per un controvalore di 31 miliardi di dollari, che includono il gruppo Pirelli, Ansaldo Energia, Snam e Terna, Ferretti Yacht, Krizia, Olio Sagra più molte altre entità minori.
Vorrei ricordare soltanto due episodi, piccoli ma indicativi della difficoltà con la quale la Cina segue le regole rispettate da tutti gli altri. Qualche anno fa un gruppo di vigili si recò nella zona di via Paolo Sarpi, considerata la Chinatown milanese, per far rispettare gli orari di carico e scarico merci degli esercenti locali. I commercianti cinesi non solo si ribellarono alle legittime richieste dei vigili, ma scesero in strada con grandi bandiere cinesi e le sventolarono come per denunciare un’aggressione ingiusta e razzista nei loro confronti. Il governo di Pechino intervenne e fece pressioni su quello italiano e l’operazione venne bloccata. In un altro caso, un importante produttore italiano di rubinetteria si ritrovò a una fiera internazionale affiancato da una ditta cinese che esponeva l’intera gamma dei suoi prodotti, copiati minuziosamente da quelli italiani e, ovviamente, a prezzi stracciati.
Scambi commerciali e reciprocità
Il rispetto della proprietà intellettuale è un concetto molto difficile da far accettare alla Cina che, da un lato ha sviluppato settori tecnologicamente avanzati facendo investimenti enormi, ma dall’altro, continua imperterrita a copiare qualunque prodotto che la interessi. La situazione è diventata tanto seria che Cecilia Malström, la commissaria europea alla concorrenza, ha annunciato un ricorso all’Organizzazione mondiale del commercio per le continue violazioni cinesi. Un problema aggiuntivo è che invece di creare un fronte comune per costringere la Cina a rispettare le regole internazionali, il presidente americano Trump ha iniziato una disastrosa politica unilaterale di imposizione di dazi che contribuisce oggettivamente ad indebolire l’Europa. La questione vera è che, come ha affermato un diplomatico anonimo citato da Handelsblatt, i cinesi ascoltano con attenzione e cortesia le lamentele ma continuano tranquillamente a mettere in pratica una strategia commerciale scorretta. Negli ultimi anni, gli investimenti cinesi all’estero sono cresciuti in modo esponenziale ma l’inverso non è possibile perché se un’impresa occidentale vuole investire in Cina deve cedere la propria tecnologia al produttore locale. In questo modo l’economia cinese riesce ad acquisire un know-how enorme senza costi di infrastrutture e ricerca e senza alcuna penalizzazione sui propri investimenti in Occidente. Inoltre, Pechino applica sui prodotti di importazione tariffe che sono spesso il doppio di quelle occidentali e non esita a servirsi di barriere non tariffarie come l’ambiente o la sanità per limitare l’import.
Lo scorso febbraio il GTAI, l’ente tedesco per il commercio estero, in collaborazione con l’Associazione delle camere di commercio tedesche, ha pubblicato uno studio in cui si afferma che il progetto BRI sta puntando su Paesi politicamente instabili e con una cornice legale incerta. Finora l’80% dei progetti finanziati dalle banche di Pechino sono andati a imprese cinesi e la regolamentazione per l’assegnazione degli appalti non è assolutamente trasparente per cui questo rimane un aspetto da chiarire assolutamente. Handelsblatt riferisce che lo scorso maggio una delegazione dell’Unione Europea, di cui faceva parte l’ex ministro dell’Economia tedesco Brigitte Zypres, si è recata a Pechino per lanciare in pompa magna la Nuova via della seta e firmare una dichiarazione congiunta. La delegazione europea ha richiesto una riformulazione del testo che avrebbe dovuto garantire “uguali opportunità per tutti gli investitori nelle infrastrutture dei trasporti”. I cinesi hanno rifiutato ogni cambiamento e il documento congiunto non è stato firmato. In un discorso, tenuto a metà aprile scorso, il presidente Xi Jinping ha affermato che la Nuova via della seta “non è una cospirazione cinese come qualcuno all’estero sta affermando”. La Cina, ha continuato, non ha intenzione di mettere in campo “giochi geopolitici che facciano solo i nostri interessi”. Se le cose stanno così, è il caso che Pechino risponda alle domande e alle perplessità finora formulate.
La grande espansione militare cinese
L’idea di una poderosa espansione dei commerci e delle infrastrutture mondiali è certamente positiva e lodevole. Il problema è che questa iniziativa è associata a un massiccio aumento degli investimenti militari e a una espansione senza precedenti della marina militare cinese che, de facto e senza rispettare la legge internazionale, sta trasformando l’enorme braccio di mare tra la Cina e l’Indonesia in una vero e proprio mare cinese. Il nome geografico di quell’area è Mar cinese meridionale ma comprende le acque territoriali di Taiwan, Filippine, Vietnam, Malesia e Indonesia.
[caption id="attachment_10659" align="aligncenter" width="450"] Xi Jinping è segretario generale del Partito comunista cinese e presidente della Repubblica popolare. A marzo scorso il limite dei due mandati presidenziali è stato eliminato per cui Xi Jinping potrà rimanere in carica a vita, in una posizione più simile a quella di un imperatore che a un politico.Xi Jinping[/caption]
La Cina rivendica in modo unilaterale la sovranità sull’intera area e ha iniziato da tempo a costruire basi militari su piccoli scogli, trasformati da enormi colate di cemento in avamposti del territorio cinese. L’articolo 136 della Convenzione di Montego Bay del 1982 definisce acque internazionali quelle che distano 200 miglia dalla costa e che, insieme al suolo e sottosuolo del mare internazionale, sono definite “patrimonio comune dell’umanità”. Nessun Paese quindi ha il diritto di impossessarsene e utilizzarlo per qualunque fine. Possiamo però immaginare quali siano le difficoltà per Paesi relativamente piccoli come le Filippine o il Vietnam nel confrontarsi con l’espansionismo militare del drago cinese.
Non è questo il luogo per approfondire un argomento complesso e articolato come la strategia militare cinese sui mari. Voglio solo mettere in evidenza che, nel contesto della politica della Nuova via della seta, la Marina militare cinese ha costruito, a partire dal 2016, una base navale a Gibuti, in un’area di enorme importanza strategica, adiacente al porto di Doraleh, di proprietà di una grande impresa cinese. Il costo della realizzazione è stato di 590 milioni di dollari e consentirà d’ora in poi alla marina militare cinese di proiettarsi in un contesto geografico sensibile come il Corno d’Africa e l’Oceano indiano. In un articolo, apparso sul Corriere della Sera del 30 aprile scorso, Danilo Taino commenta che il progetto BRI “è strategicamente centrale all’idea di un blocco economico, ma in fondo anche politico, di Eurasia contrapposto alla sfera transatlantica. Eurasia nella quale Pechino avrebbe naturalmente un ruolo dominante”. A Taino è forse sfuggito che Eurasia, insieme a Eastasia e Oceania, è il nome che lo scrittore George Orwell ha dato ai tre raggruppamenti in costante guerra tra di loro all’interno del romanzo 1984, sì, proprio quello del Grande fratello. Forse dovremmo cominciare a preoccuparci un po’.]]>
Xi Jinping è segretario generale del Partito comunista cinese e presidente della Repubblica popolare. A marzo scorso il limite dei due mandati presidenziali è stato eliminato per cui Xi Jinping potrà rimanere in carica a vita, in una posizione più simile a quella di un imperatore che a un politico.Xi Jinping[/caption]
La Cina rivendica in modo unilaterale la sovranità sull’intera area e ha iniziato da tempo a costruire basi militari su piccoli scogli, trasformati da enormi colate di cemento in avamposti del territorio cinese. L’articolo 136 della Convenzione di Montego Bay del 1982 definisce acque internazionali quelle che distano 200 miglia dalla costa e che, insieme al suolo e sottosuolo del mare internazionale, sono definite “patrimonio comune dell’umanità”. Nessun Paese quindi ha il diritto di impossessarsene e utilizzarlo per qualunque fine. Possiamo però immaginare quali siano le difficoltà per Paesi relativamente piccoli come le Filippine o il Vietnam nel confrontarsi con l’espansionismo militare del drago cinese.
Non è questo il luogo per approfondire un argomento complesso e articolato come la strategia militare cinese sui mari. Voglio solo mettere in evidenza che, nel contesto della politica della Nuova via della seta, la Marina militare cinese ha costruito, a partire dal 2016, una base navale a Gibuti, in un’area di enorme importanza strategica, adiacente al porto di Doraleh, di proprietà di una grande impresa cinese. Il costo della realizzazione è stato di 590 milioni di dollari e consentirà d’ora in poi alla marina militare cinese di proiettarsi in un contesto geografico sensibile come il Corno d’Africa e l’Oceano indiano. In un articolo, apparso sul Corriere della Sera del 30 aprile scorso, Danilo Taino commenta che il progetto BRI “è strategicamente centrale all’idea di un blocco economico, ma in fondo anche politico, di Eurasia contrapposto alla sfera transatlantica. Eurasia nella quale Pechino avrebbe naturalmente un ruolo dominante”. A Taino è forse sfuggito che Eurasia, insieme a Eastasia e Oceania, è il nome che lo scrittore George Orwell ha dato ai tre raggruppamenti in costante guerra tra di loro all’interno del romanzo 1984, sì, proprio quello del Grande fratello. Forse dovremmo cominciare a preoccuparci un po’.]]>
Pubblicazione gratuita di libera circolazione. Gli Autori non sono soggetti a compensi per le loro opere. Se per errore qualche testo o immagine fosse pubblicato in via inappropriata chiediamo agli Autori di segnalarci il fatto e provvederemo alla sua cancellazione dal sito