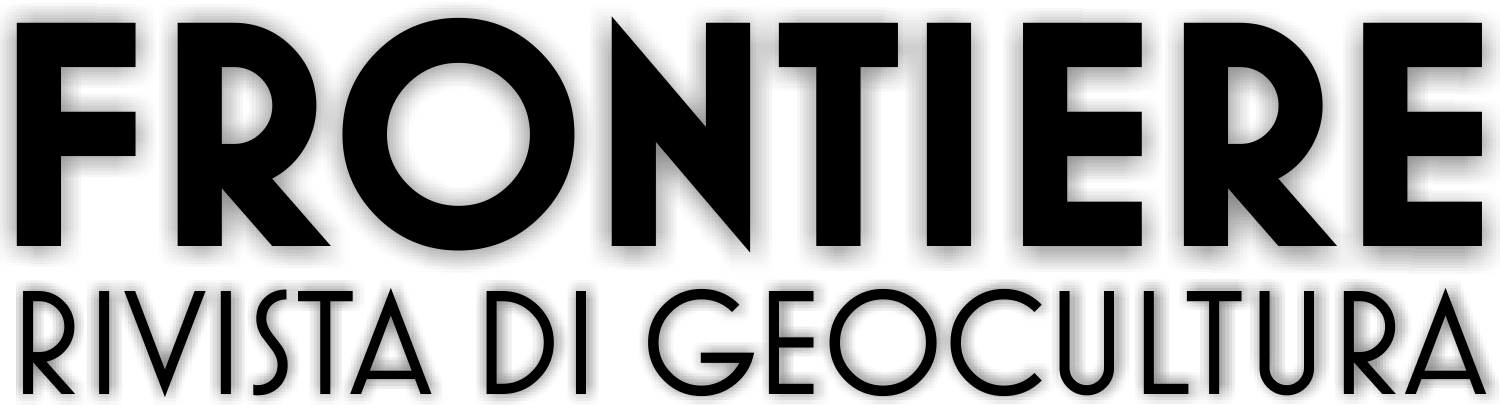di Alberto Castaldini*
Ebrei immaginari ed ebrei reali, fra rappresentazione e narrazione, lungo labili frontiere segnate da uno sguardo di lunga durata. La recente traduzione italiana di un volume dello storico delle religioni romeno Andrei Oişteanu, L’immagine dell’ebreo. Stereotipi antisemiti nella cultura romena e dell’Europa centro-orientale, pubblicato a Livorno dalle edizioni Belforte, illustra dati iconografici e ricostruisce meccanismi sociali, psicologici e religiosi che nel corso del secondo millennio hanno definito gli stereotipi antisemiti in Europa centro-orientale, con una particolare attenzione allo spazio danubiano-carpatico, esposto per la sua posizione agli influssi sia dell’area pontico-mediterranea sia di quella mitteleuropea. Protagonista del libro è l’ebreo immaginato, che dalla cultura popolare passa alla cultura delle élite – arti visive, letteratura, polemica socio-politica – da Bucarest a Varsavia, da Budapest a Leopoli, narrato da visioni proprie non solo dell’Europa fra il Danubio e il Dnepr, ma anche di quella occidentale e mediterranea, con percezioni forse meno connotate, ma non meno estremizzate in alcune espressioni.
Se, ad esempio, le maschere popolari dell’ebreo nelle campagne della Polonia e della Romania nord-orientale, descritte nel volume di Oişteanu, mostrano tratti spaventosi e nel contempo apotropaici (in ossequio forse ad arcane ritualità comunitarie e stagionali), a San Fratello, antica colonia ligure-piemontese in provincia di Messina, durante la cosiddetta Festa dei giudei nel corso della Settimana Santa, i paesani indossano un costume composto da una giubba rossa e dorata, con strisce di stoffa gialle o bianche, e calzoni di mussola rossa. Sul capo hanno un elmo; la maschera del volto è di sberleffo. Il richiamo ai legionari romani come ai diavoli è evidente. Dunque, gli ebrei immaginati vengono associati, o mimeticamente confusi, agli attori malvagi, fisici e persino metafisici, del racconto evangelico, in una narrazione che sembra non avere tempo né luogo. Ne è un esempio, senza dubbio più rozzamente stereotipato, il carnevale di Aalst, non lontano da Bruxelles, cuore istituzionale dell’Unione Europea. Ancora nel febbraio del 2020, quando la pandemia di Covid non era dilagata in Europa, sono sfilati carri e allegorie di tenore antisemita oggetto di aspre critiche.
Le parole e lo sguardo, l’espressione e la visione, possono avere registri diversi, ma ci permettono di cogliere differenze e analogie lungo direttrici geo-culturali che, inaspettatamente, uniscono, anche in modo diacronico (e ciò vieppiù sorprende, se pensiamo al Belgio laico e multiculturale del XXI secolo), i centri ottocenteschi della Bucovina o della Moldavia ai borghi della Sicilia, i villaggi della Podolia con le signorie padane in Età moderna.
Mantova, ultimo scorcio del ‘400. Daniel Norsa, tornato dalla vicina Villafranca dove gestiva un banco di prestito, acquista una casa, ottenendo dalle autorità di poter rimuovere un’immagine sacra sulla facciata. Il popolo non gradisce e durante la processione dell’Ascensione del 1495 i mantovani protestano. Norsa invia una supplica a Francesco II Gonzaga, chiedendo garanzie. Gli viene concesso un “salvacondotto”, ma il 31 luglio di quell’anno, il marchese, che poco tempo prima aveva comandato i confederati italiani nella battaglia contro Carlo VIII a Fornovo e che era stato accusato di non aver inferto un colpo decisivo ai francesi, subodorando il crescente malcontento, ordina il ripristino dell’immagine. Ma a Mantova si pensa di fare di più, e la casa dei Norsa viene abbattuta. Al suo posto si costruisce una chiesa dedicata a Santa Maria della Vittoria per celebrare la (parziale) gloria gonzaghesca sulle rive del Taro. Inoltre al Mantegna si commissiona una splendida tavola (oggi al Louvre) raffigurante la Madonna che raccoglie sotto il suo manto Francesco Gonzaga, mentre un pittore più modesto realizzerà un secondo quadro, la Madonna degli Ebrei, dove ai piedi del trono della Vergine, quasi fossero devoti committenti, sono ritratti i Norsa con la rotella di stoffa gialla (“il segno”) e il volto smarrito. Nella parte superiore dell’opera due angeli reggono un cartiglio con una scritta: “Debellata hebraeorum temeritate”. Come scrisse René Girard, circa il noto paradigma interpretativo sulle origini sacrificali delle società umane, affinché “possa polarizzare le tendenze aggressive […] bisogna che la vittima non sia né troppo né troppo poco estranea a questa stessa comunità”. La vicenda mantovana presenta questi tratti mimetici che adombrano, ma non risolvono affatto, il meccanismo dell’intolleranza: anzi, lo esasperano. Superata la minaccia francese, scongiurata la crisi politica locale, quel cartiglio dipinto indica allo sguardo dei posteri la vittima designata e le cause della violenza collettiva nei suoi confronti. Si proiettano così nel tempo le tensioni comunitarie sulla figura dell’ebreo, che da solo incarna la crisi del marchesato, essendo ritenuto colpevole, per il suo raggiunto status, di aver pericolosamente indifferenziato l’ordine sociale, in nome di una presunta aspirazione mimetica (oggi la chiameremmo integrazione) che quel quadro “riparatore” ribadirà sul piano visivo. I Norsa, a distanza di cinque secoli, ci guardano ancora con aria interrogativa in una cappella laterale della basilica di Sant’Andrea.

Di diverso tenore, ma per ciò che concerne le forme e non il fine, è un ciclo di affreschi sulla Passione nel battistero del duomo di Chieri in provincia di Torino, risalente agli anni Trenta del ‘400. Oggi sappiamo che il loro autore è un pittore piemontese, Guglielmetto Fantini. Prima della Seconda guerra mondiale si pensava fossero di scuola tedesca. L’opera presenta infatti tratti espressionistici che riconducono alle tradizioni pittoriche dell’Europa centrale: geo-mimesi delle forme fatta di colori accesi, figure dal tratto incisivo, atteggiamenti fortemente connotati. Nell’episodio del tradimento di Giuda spiccano visi grotteschi, tratti grifagni e financo diabolici sia in colui che riceve i denari del tradimento, sia in quanti gli stanno accanto: è il brutto, il deformato come simbolo della malvagità del cuore e del peccato. Dramma iconografico quello di Chieri, proiettato nelle sue forme oltre le Alpi ma non meno contestuale alla cornice sociale e politica locale, nell’evoluzione istituzionale che segna l’intera penisola nella prima Età moderna. Il 17 giugno 1430 Amedeo VIII di Savoia (che sarà in seguito l’ultimo antipapa col nome di Felice V) emana gli Statuti generali, contenenti, fra l’altro, una serie di disposizioni riguardanti gli ebrei del ducato. Il duca garantisce loro la protezione come singoli e comunità; essi però non devono praticare l’usura, né essere agenti per conto dei cristiani. Eppure continueranno ad essere accusati di falsa testimonianza, oltre che di avversione alla religione cristiana: una minaccia stigmatizzata nel severo monito pittorico di Chieri che visibilmente addita un’intera comunità, differenziandola violentemente per scongiurare ogni pericolosa mimesi.
Ho cercato di spiegare le dinamiche metamorfiche di questo ricorrente fenomeno, dal Medioevo fino al Secolo breve, in un volume, L’ipotesi mimetica. Contributo a una antropologia dell’ebraismo, apparso vent’anni fa per Olschki, nella “Biblioteca di Lares”, pochi giorni dopo l’abbattimento delle Torri Gemelle di New York. Quel concomitante evento epocale che sconvolse il mondo, e che sembrò nuovamente contrapporlo fra due rinnovati blocchi – quello delle libertà e quello della barbarie, pericolosamente confusi dalla marea post-moderna – produsse conseguenze che svuotarono molte delle strategie impiegate nel conflitto mimetico tradizionale (non solo in relazione agli ebrei), e che la “cortina di ferro” aveva in qualche modo regolato per decenni. Oggi l’antica tentazione mimetica che genera imitazione e passione, tensioni e sofferenze collettive, supera con maggiore rapidità argini geografici e confini sovrani. L’epoca della crisi globale, internazionale e comunitaria, ripropone sì quei meccanismi intolleranti, ma con nuove modalità espressive e obiettivi più diversificati e imprevisti. Il crescente relativismo ha infatti sparigliato sul piano assiologico non solo le categorie tradizionali, ma persino i temi storicamente critici al punto da mutare i connotati più accesi dello scontro, la cui espressione guerreggiata viene relegata dai media alle periferie del pianeta. In realtà una battaglia si consuma violenta sui social come nelle nostre piazze, sotto il nostro sguardo, nonostante le limitazioni imposte dal Covid.
Diversamente dalla Padania quattrocentesca come dalla declinante Mitteleuropa fra Otto e Novecento, la dinamica mimetica nella società globale sembra generare oggi uno sbocco violento non solo nella rappresentazione del pregiudizio, ma anche nella sua condanna, risultando essa non meno intollerante, come è accaduto nelle sue più recenti manifestazioni in Europa e negli Stati Uniti dove statue e immagini sono state oggetto di una pubblica “esecuzione in effigie”.

Che la lotta alla discriminazione delle minoranze, in nome dei diritti, debba risolversi in una singolare eterogenesi dei fini, tanto da culminare in episodi di dis-integrazione comunitaria, costituisce un fenomeno complesso e preoccupante le cui cause non è possibile nemmeno abbozzare nell’economia di questo mio intervento. Ma che lo sguardo attraverso cui l’uomo incontra e sperimenta un mondo oggi lacerato tra riaffermazione e annullamento delle differenze, sia urgentemente chiamato a smontare le narrazioni strumentali e divisive sull’alterità, mi sembra una priorità che chiama in causa ciascuno di noi. E ciò proprio per sviluppare una reale consapevolezza culturale, oltre che etica, senza la quale non è possibile giudicare e comprendere sia l’identità sia l’alterità nel loro naturale e storico confronto. Le generazioni future, infatti, ci osservano e ci interrogano, chiedendo già da ora una risposta attraverso il nostro sguardo sul presente.
*Giornalista e professore nella Facoltà di Teologia Greco-Cattolica dell’Università Babeş-Bolyai di Cluj (Romania).
 Andrei Oişteanu, L’immagine dell’ebreo. Stereotipi antisemiti nella cultura romena e dell’Europa centro-orientale (Belforte Salomone, pagine 901, euro 38,00)
Andrei Oişteanu, L’immagine dell’ebreo. Stereotipi antisemiti nella cultura romena e dell’Europa centro-orientale (Belforte Salomone, pagine 901, euro 38,00)
Pubblicazione gratuita di libera circolazione. Gli Autori non sono soggetti a compensi per le loro opere. Se per errore qualche testo o immagine fosse pubblicato in via inappropriata chiediamo agli Autori di segnalarci il fatto e provvederemo alla sua cancellazione dal sito