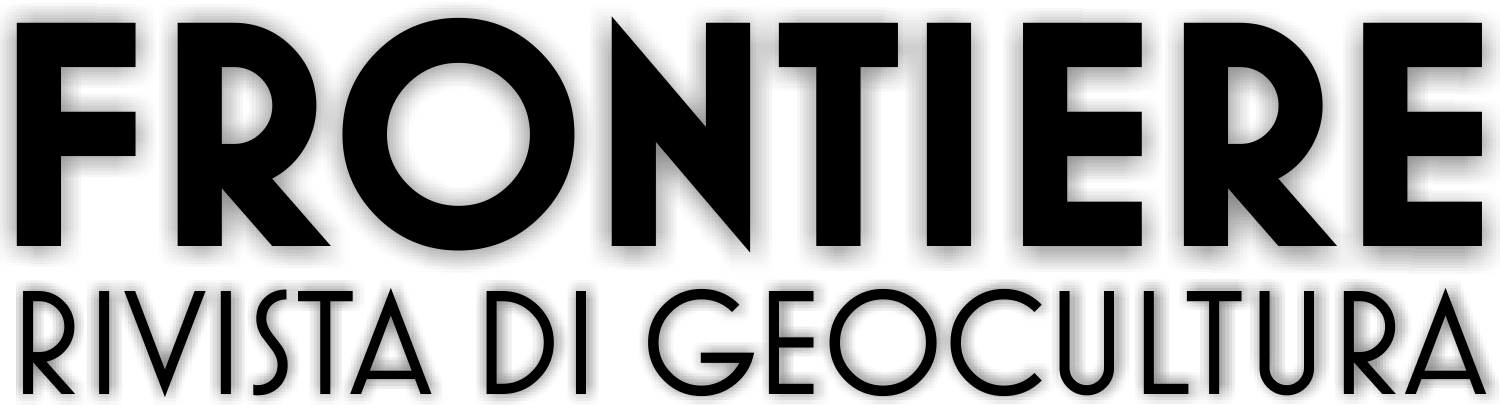Una magistrale pagina da “Il rosso e il nero” di Renzo de Felice Tutti a casa
Dal primato della politica al primato della storia: qual e il nesso che lega il malessere morale, culturale e politico di oggi con i nodi della storia di ieri? Perché la fine del fascismo e la nascita della Repubblica, la Resistenza e la Repubblica sociale di Salò sono vissuti come un “atto mancato” della ricerca storiografica? La disfatta dell’8 settembre, data tragica contemporanea a cui si fanno risalire i mali morali di oggi, fu inevitabile? Come e che si disfece un intero Paese, un esercito si sciolse come neve al sole, una nazione perse la sua identità? Perché sentiamo ancora quel “tracollo eticopolitico” come una specie di peccato originale della Repubblica italiana? Di chi fu la colpa politica? Di chi fu la colpa morale? Di chi fu la colpa militare? Infine: qual e la verità storica?
‘Abbasso tutti , c’era scritto su una spalletta del Lungotevere. L’8 settembre 1943, giorno dell’armistizio, i giornali italiani uscirono listati a lutto. Comincia in tal modo lo svuotamento del senso nazionale che fa di quel giorno la data simbolo del male italiano. E’ il carattere stesso di un intero popolo che viene messo in discussione. Per capire il clima, meglio dei documenti della storia, è l’invenzione narrativa che ci dà lo spirito del tempo. Al cinema come nella letteratura, che da questo punto di vista “Tutti a casa” di Luigi Comencini con Alberto Sordi ha lo stesso valore de “Il sentiero del nidi di ragno” di Italo Calvino. Anche se, fra tante pagine tragiche, io preferisco la cinica, e altrettanto sofferta, rappresentazione di Curzio Malaparte che, nella “Pelle”, 1’8 settembre lo racconta così: “Un magnifico giorno… Tutti noi ufficiali e soldati facevamo a gara a chi buttava più ‘eroicamente’ le armi e le bandiere nel fango… Finita la festa, ci ordinammo in colonna e cosi senz’armi, senza bandiere, ci avviammo verso i nuovi campi di battaglia, per andare a vincere con gli Alleati questa guerra che avevamo già persa con i tedeschi… E, certo assai più difficile perdere una guerra che vincerla. A vincere una guerra sono tutti buoni, non tutti sono capaci di perderla”. È stato il grande storico dell’Italia liberale, Rosario Romeo, a intuire per primo che, con la seconda guerra mondiale, si rivela la debolezza ”etico-politica” del sentimento nazionale ancora legato alle radici culturali, ma anche psicologiche e caratteriali, del passato preunitario.È la borghesia italiana che manca il suo compito storico evitando di schierarsi da una parte o dall’altra in attesa, seppure nel quadro di una generale avversione verso l’occupazione tedesca, dello svolgersi degli eventi. La fuga di Vittorio Emanuele e del suo primo ministro Pietro Badoglio, del suo capo di Stato maggiore Vittorio Ambrosio e di buona parte dei vertici militari, l’abbandono alla mercè del nemico (vecchio e nuovo) delle truppe nei territori d’occupazione e la dissoluzione dell’esercito in Italia, subito dopo l’annuncio dell’ armistizio, hanno segnato e minato per sempre la memoria collettiva nazionale. Il termine dissoluzione ci dà solo una pallidissima idea della realtà di quei giorni: “Le forze armate italiane non esistono” era la cruda constatazione, già il 10 settembre, dell’alto comando tedesco. Diversamente erano andate le cose nell’ottobre del 1917, dopo la sconfitta di Caporetto, quando la borghesia italiana era riuscita a raccogliere le forze per scongiurare la catastrofe della patria: nessuno mise in dubbio l’esito finale della guerra e, grazie al Piave, a Caporetto segui Vittorio Veneto. Tutto era cominciato male, nel 1940. La borghesia italiana che, volente o nolente, ormai aveva finito per identificarsi col fascismo, aveva visto di buon occhio la fine della “non belligeranza”, immaginando di dover combattere una “guerra breve”. Nel sentimento comune, dopo il crollo verticale della Francia, un pugno di morti e poche settimane di combattimenti sarebbero dovuti bastare per guadagnarsi il diritto di sedere al tavolo della pace dalla parte dei vincitori. Con questo spirito, gli stessi figli della borghesia fascista affrontarono la guerra come un grattacapo da sopportare, una seccatura da evitare, una corvèe da scansare. Ma quando, grazie alla fermezza di Winston Churchill, da “breve” si fece “lunga” e fu subito dura (ci furono le prime sconfitte in Grecia, in Africa settentrionale, a Taranto), la guerra di Mussolini per i borghesi fascisti come per gli antifascisti, ma soprattutto per gli afascisti, divenne una “guerra imposta”. Si generò un clima politico-culturale “all’italiana”, più furbetto che cinico, un po’ opportunista, che sarà all’origine della faglia morale dell’8 settembre.
– 8 Settembre o 10 giugno–
In un piccolo libro del 1945, “Quasi una vita”, Corrado Alvaro dipinge un quadro lucido e tragico di questo stato d’animo: “Gran parte dell’Italia si augurò la disfatta. Gli italiani credettero a Radio Londra, sperarono sempre più ardentemente nella sconfitta, l’aiutarono, la predicarono: eppure avevano figli in Africa, nei Balcani, in Russia. (…) La solidarietà e il patriottismo e senso della responsabilità individuale andavano dispersi e uccisi”. Cinquant’anni dopo, sulla rivista liberalcomunista “Reset”, Norberto Bobbio conferma: ”Avevamo perduto cosi radicalmente l’idea di nazione da desiderare che l’Italia perdesse la guerra”. Per Bobbio la “data tragica” della nazione è 10 giugno 1940, giorno della dichiarazione di guerra alla Francia e all’Inghilterra. Ne abbiamo discusso in occasione del cinquantenario del 25 aprile su “Panorama” e “l’Unita”. Dice Bobbio: “Caro De Felice, è questa la valutazione che ci divide: secondo me la stragrande maggioranza degli italiani non fu favorevole all’entrata in guerra”. Bobbio sbaglia: il sentimento comune degli italiani, alla fine degli anni Trenta, era di totale fiducia per Mussolini; controllando bene le cifre, si scopre che la partecipazione volontaria alla seconda guerra mondiale fu maggiore che nella Grande Guerra. I dati pubblicati nel penultimo volume della biografia, “Mussolini L’Alleato” vanno corretti: ho potuto stabilire infatti che i militari cercavano di minimizzare ii fenomeno facendo passare molti volontari per arruolati. Dopo le cocenti sconfitte in Africa e in Russia, anche il vertice fascista e lo stesso Mussolini si erano convinti che bisognasse trovare una nuova via di uscita. Ma non era facile. Infatti, e dalla ricerca di queste soluzioni che si evince tutta la superficialità della classe politica e militare, fascista e monarchica, che in tutto quell’armeggiare fu guidata solo dalle ambizioni di carriera e dalle possibilità di avanzamento. Si comincia con gli sforzi per convincere Hitler a un accordo con Stalin o almeno a una stabilizzazione del fronte orientale, in modo da spostare tutto il baricentro della potenza tedesca sul Mediterraneo contro gli Alleati; si prosegue con la pretesa che i tedeschi accettino un’uscita unilaterale dalla guerra degli italiani; si finisce con l’assurda idea di Dino Grandi (che pure era un uomo di molte qualità) di un ribaltamento del fronte, con l’immediato passaggio dell’Italia a fianco degli Alleati. Evento tanto incredibile allora, quanto impossibile dopo. Con tutte le conseguenze che ancora scontiamo. C’e un passo di Rosario Romeo che da un giudizio definitivo sui vertici militari e politici del fascismo: “Dopo aver corso l’avventura a fianco della Germania fino a quando ii successo parve a portata di mano, si scoprirono antifascisti e antitedeschi alla venticinquesima ora, mostrarono in questa occasione di essere non solo tecnicamente ma anche moralmente e intellettualmente troppo inferiori alle esigenze di un conflitto che coinvolgeva il destino di interi popoli e non poteva essere chiuso con manovre ispirate allo stile della settecentesca politica di gabinetto”. Sono d’accordo. Se ne deve dedurre che nemmeno alla fine, quando tutto era perduto, si era compresa la vera natura di questa guerra. Gli unici che avevano le idee un po’ più realistiche erano i comunisti, per via dei loro rapporti stretti e privilegiati con Mosca.
Colpa del Re e di Badoglio o di chi
Le drammatiche esperienze della “guerra lunga” ebbero un effetto paralizzante, a conferma della ” debolezza etico-politica” del paese, che non può essere spiegato solo con gli esiti negativi del regime fascista. La guerra ha morso in profondità le carni della nazione, materialmente e moralmente: fa da detonatore al coacervo di interessi e compromessi che teneva in piedi il regime. Senza la catastrofe, la classe dirigente italiana, la borghesia fascista e financo i ceti popolari non avrebbero avuto né l’interesse né la forza di scrollarsi di dosso il fascismo. E nemmeno Mussolini. E in questo clima che matura il trauma dell’8 settembre. “La guerra continua”: il 25 luglio, con quell’infelice postilla alla caduta del regime, Pietro Badoglio, primo ministro, aveva messo le premesse alla crisi morale e istituzionale, individuale e collettiva, che sarebbe sopraggiunta 45 giorni dopo. Nella profonda sfiducia in sé e nello Stato, la stragrande maggioranza degli italiani, pur nel generale distacco dal fascismo accompagnato da una radicata ostilità verso i tedeschi, non aveva altro anelito che non fosse attendere la fine della guerra, cercando di sfuggire a essa, quasi sperando di scomparire pur di salvarsi. Sembrava la soluzione più facile, più scaltra, più a portata di mano. Come se anche questo, in quella situazione, non comportasse gravissimi pericoli, una forte tensione etico-politica, costi morali e materiali che bisognava pur pagare. Un pericolo che sembrava temperato dall’autoillusione che gli Alleati stessero per sbarcare al Nord piuttosto che al Sud, a Genova piuttosto che a Salerno, nel Lazio come in Sardegna. Una speranza che andava insieme alla supposizione che i tedeschi si sarebbero ritirati da gran parte del paese, come si credeva di desumere dai loro primi movimenti. La bella favola non durò più di dieci giorni. L’armistizio aveva chiuso per l’Italia il tempo della guerra fra Stati (combattuta, salvo che in Sicilia, fuori dai confini), ma aveva di fatto aperto una fase ancora più drammatica: la Guerra di liberazione del suolo nazionale (contro l’occupante ex alleato, diventato nuovo nemico) e la guerra civile (per definizione tutta interna ai confini della patria). La “fuga di Pescara” e la mancata difesa di Roma” sono i due capisaldi della costruzione simbolica che spiega e consente di giustificare la mancata “reazione morale” di un popolo intero, ma sono anche il principale atto d’accusa contro la monarchia, la sua classe dirigente, il suo esercito. Che poi il re si fosse messo d’accordo con il feldmaresciallo Albert Kesselring per scappare da Roma o piuttosto che Kesselring, con i guai che aveva quel giorno, abbia preferito lasciar sfilare corteo fuggiasco, preoccupato dall’idea di provocare un guizzo di reazione a favore del re fatto prigioniero, non è mai stato dimostrato. E conta poco. La mancata difesa di Roma ha finito per assumere un valore emblematico nell’immaginario collettivo. Una reazione italiana avrebbe cambiato ii significato storico della fuga del re, ma non avrebbe modificato il corso degli eventi. La vicenda fu torbida. Riprovevole il comportamento di chi vi ebbe parte. Col senno di poi ci si può rammaricare che all’Italia sia mancato un antifascista con le qualità di Charles De Gaulle, un soldato con l’autorità di appellarsi agli italiani per la difesa della patria. Rimane ii fatto che l’ordine di reagire non fu diramato, e i tedeschi capovolsero in tre giorni la situazione di svantaggio numerico in cui si trovavano. Attorno a Roma c’erano sei divisioni italiane contro due tedesche. C’erano stati combattimenti, ma il grosso delle forze italiane non era stato messo in campo, rimasto senza ordini si era ben presto dissolto. Per i tedeschi fu facile ottenerne la resa. Cosi la capitale d’Italia divenne Città Aperta al comando del generale Calvi di Bergolo, che doveva garantire ii cosiddetto, non senza pompa, “Patto di Roma”. Da qui, a sostenere che la difesa di Roma avrebbe cambiato ii corso della guerra e avrebbe costretto gli anglo-americani a scendere in campo per affiancare l’esercito italiano contro tedeschi, però ce ne passa… L’”operazione Avalanche”, lo sbarco a Salerno del 9 settembre, deciso subito dopo la caduta di Mussolini quindi prima dell’armistizio, si era risolto in un disastro strategico. Non solo non aveva tagliato la strada alle truppe tedesche che si ritiravano dal Sud, ma aveva dato a Kesselring il tempo di gettare le basi della “linea Gustav”che avrebbe bloccato per mesi e mesi gli anglo-americani: Roma occupata serviva a garantire le vie di comunicazione verso il Nord. Anche l’armistizio fu un vero pasticcio, fra pseudomachiavellismi degli italiani, bluff degli americani e risentimenti degli inglesi. Da una parte (il generale Giuseppe Castellano) si spingeva verso la collaborazione italiana con un capovolgimento immediato del fronte, mentre dall’altra (Badoglio e Vittorio Emanuele) si tentava di procrastinare l’annuncio con mille scuse, come se in loro ii massimo timore fosse proprio quello di sfuggire alla reazione dei tedeschi. Che, sulle prime, non si accorsero di nulla. E infatti l’annuncio fu dato da Eisenhower. Al generale americano importava soprattutto render pubblico ii patto prima che Malta fosse occupata dai tedeschi. Fu un susseguirsi di menzogne. Un gioco delle parti fra marescialli, generali e ammiragli, fra Badoglio e Castellano, Roatta e Ambrosio, Sorice e de Courten, Caviglia e Carboni… Si può riconoscere che Vittorio Emanuele III, pur in frangenti cosi contraddittori, riusci a ottenere due risultati decisivi per la sopravvivenza dello Stato italiano. Esercitò una funzione di garanzia nei confronti degli Alleati: era il legittimo garante delle firme che il generale Castellano aveva messo sotto “l’armistizio breve” a Cassibile e Pietro Badoglio sotto “l’armistizio lungo” a Malta. Garanti, poi, quella continuità di governo che altrimenti, alla fine della guerra civile, sarebbe stata moralmente rivendicata dalla Rsi. Gli servì a poco. La condanna della storia arrivò senza appello: la fine dell’istituzione monarchica per volontà del popolo sovrano espressa attraverso il primo referendum d’Italia nel 1946.
Fu sciopero morale?
Vale la pena chiedersi cosa sarebbe successo se Badoglio avesse dato l’ordine di combattere contro i tedeschi? Non credo: tirando le somme, fu proprio il modo con cui si arrivò all’armistizio che rese inevitabile la dissoluzione delle forze armate. Perché quell’aria di sfiducia che attanagliava la nazione, per le fatiche di tre anni di guerra, per le frustrazioni della mancata fine dopo ii 25 luglio, avrebbe dovuto risparmiare l’esercito? Con la certezza che le prime vittime, i primi a pagare sarebbero stati proprio i militari, in mancanza di ordini, in assenza di obiettivi chiari, gettate le armi, l’unico pensiero fu quello di procurarsi un abito civile, evitare di essere fatti prigionieri, raggiungere con qualsiasi mezzo i propri paesi di origine. La reazione tedesca, forse sottovalutata dagli Alleati, ebbe un naturale effetto deterrente sulla truppa italiana. La consapevolezza della proverbiale disciplina, unita alla spietatezza, confermò l’idea della forza germanica e giustificò la nazione allo sbando, con l’accettazione della propria debolezza. Le conseguenze furono catastrofiche: i militari deportati in Germania saranno, alla fine della guerra, circa un milione. Alle colpe della truppa corrispondevano, elevate alla potenza, le colpe degli ufficiali. Dove ci furono ordini precisi, vuoi per senso dell’onore o per odio antitedesco, la resistenza fu efficace e il processo di dissoluzione più contenuto e dignitoso. Nella stragrande maggioranza gli ufficiali vennero meno ai loro doveri. Il cattivo esempio dilagò giù giù per i gradi… Quelli che prestavano servizio presso ii Comando supremo e lo Stato maggiore lasciarono senza ordini i comandi locali e si eclissarono. Furono in pochi ad affrontare il dramma dell’8 settembre senza calpestare patriottismo e dignità nazionale, etica militare e solidarietà civile. Comportamenti cosi diffusi difficilmente possono trovare una giustificazione ideologico-politica. La spiegazione e nella condizione culturale e morale dell’Italia in quel momento: 1’8 settembre, ci fu uno “sciopero morale”. “Il fatto che i popoli non si comportino eroicamente nella sventura, non è una novità…” ha detto lo storico francese Francois Furet a proposito della Francia fulminata dalla disfatta del giugno 1940. L’osservazione è giusta, ma il caso italiano è un unicum nella storia mondiale, per dimensione e peculiarità. A Furet si può rispondere con una citazione di un maestro della storia italiana, Vittorio De Capraris: “Tra il 1943 e il 1944 non v’era certo la nostalgia del regime defunto, ma qualcosa di più grave: attonito sbigottimento e percosso stupore per la sconfitta, stanchezza di un conflitto immane e resa psicologica innanzi all’estrema rovina, come di chi, dopo aver combattuto invano contro forze soverchianti, si anima al fine e si ritira dalla lotta per lasciarsi morire”
[simpleazon-link asin=”8885987958″ locale=”it”]Rosso e nero[/simpleazon-link]
[simpleazon-image align=”none” asin=”8885987958″ locale=”it” height=”160″ src=”http://ecx.images-amazon.com/images/I/41qdAPfzzZL._SL160_.jpg” width=”102″]
]]>Pubblicazione gratuita di libera circolazione. Gli Autori non sono soggetti a compensi per le loro opere. Se per errore qualche testo o immagine fosse pubblicato in via inappropriata chiediamo agli Autori di segnalarci il fatto e provvederemo alla sua cancellazione dal sito