Le politiche trumpiane non decollano Occorre innanzitutto ricordare che mentre Trump inseriva all’interno del proprio gruppo dirigente individui a lui vicini legati all’estrema destra e con trascorsi “moscoviti” assai poco chiari, venivano contestualmente nominate in seno all’esecutivo USA personalità che con le idee di politica estera di Trump poco avevano a che fare, come, ad esempio, James Mattis, segretario alla Difesa in carica, Mike Pompeo, l’attuale direttore della CIA e, più recentemente, H.R. McMaster (nominato in seguito alle dimissioni del controverso Michael T. Flynn). In tal senso si potrebbe ritenere che mentre Trump si sforzava di introdurre propri uomini nelle posizioni chiave della nuova compagine governativa, nei fatti coloro che all’interno del partito repubblicano si opponevano alla nuova deriva “trumpista” nazional-populista hanno contestualmente cercato di imporre al nuovo “incostante” ed “inesperto” presidente eletto propri uomini che nei fatti avrebbero potuto porre un veto nei confronti di determinate politiche trumpiane ritenute del tutto inammissibili da parte del fronte “tradizionalista” dell’intera compagine politica e governativa americana. Ciononostante i primi mesi dell’era Trump sono stati caratterizzati da uno scivolone dietro l’altro per il nuovo inquilino della Casa Bianca (fatto che non deve essere dispiaciuto ai suoi oppositori), i cui rovesci hanno minato profondamente le fondamenta della sua azione politica. In primo luogo il continuo richiamo, anche istituzionale, alle ingerenze russe che hanno favorito la sua ascesa alla presidenza ha costituito una costante spada di Damocle nei confronti dell’operato di Donald Trump, nei fatti delegittimando passo dopo passo una vittoria elettorale conquistata in certa parte grazie ai buoni uffici dei servizi segreti di Mosca e all’opera di mediazione di uomini appartenenti alla cerchia ristretta di Trump stesso e ben inseriti nella rete di relazioni intessute dal Cremlino. Appare evidente che una situazione così imbarazzante ed oltretutto inedita in seno al cuore pulsante della capitale Washington deve aver indotto gli apparati burocratici e l’establishment governativo americano a cercare una strada atta a porre il presidente di fronte ad una scelta ovvero tornare verso una politica estera più tradizionale oppure attendersi presto o tardi un’inchiesta sul proprio operato ed un conseguente stato di accusa. La controversa proposta di bandire l’ingresso negli Stati Uniti agli immigrati di religione islamica provenienti da sette Paesi musulmani (osteggiata a più riprese dai tribunali americani), le “dispute” tra Trump, l’Europa, il Canada e l’Australia in tema di migranti, l’ossessione relativa alla costruzione di un muro posto al confine con il Messico, i pessimi rapporti con la stampa nazionale ed estera e l’incredibile scivolone sull’Obamacare hanno complessivamente contribuito ad erodere il consenso popolare di Trump, conducendo la sua confusa presidenza verso il probabile esito di una fine prematura. Il confronto in essere tra la Casa Bianca da un lato e i servizi di sicurezza dall’altro ha indubbiamente condotto ad una spaccatura all’interno del governo americano, nei fatti creando le condizioni per una possibile paralisi dell’azione politico-diplomatico-militare degli Stati Uniti nel contesto globale. Le politiche di bilancio promosse da Trump, tendenti a promuovere un consistente aumento delle spese militari, unite ad un drastico calo delle risorse allocate per le attività della diplomazia statunitense, possono essere lette nel contesto di una lotta in corso tra poteri dello Stato nella quale il presidente abbia cercato di tenersi a galla favorendo gli uni e danneggiando gli altri con lo scopo di racimolare alleati nell’ambiente dell’esercito. Se tale situazione potrebbe apparire in un certo qual modo inquietante, la visione di Trump nel campo dell’economia ha posto ulteriori seri dubbi sulle sue reali intenzioni politiche. Infatti le stesse proposte economiche tese a rilanciare sia un ritorno al protezionismo che politiche legate ad una sorprendente espansione del ruolo dello Stato come motore economico primario del complessivo sistema produttivo-finanziario americano ricordano analoghe esperienze promosse negli Stati Uniti nel primo dopoguerra a seguito della Grande Depressione, nonché, per certi versi, sia l’utilizzo massiccio della leva della spesa pubblica che la dilatazione dei numeri del pubblico impiego possono suggerire tristi paragoni con Paesi che nella loro storia hanno conosciuto regimi illiberali ed autoritari. Lo scenario internazionale Sul piano estero il tracollo delle speranze dei ribelli siriani di giungere ad una vittoria finale contro Assad a seguito della caduta di Aleppo, ha coinciso con la ripresa dei negoziati prima ad Astana (con Russia, Iran e Turchia a fungere da sponsor) e poi a Ginevra sotto l’egida dell’ONU. Parimenti Russia, Turchia ed Iran hanno imbastito un cessate il fuoco il quale tuttavia non ha saputo fermare concretamente i combattimenti. La posizione turca in questi ultimi mesi si è ulteriormente chiarita rispetto alle evoluzioni che era stata costretta ad intraprendere a fronte del progressivo indebolimento delle milizie ribelli in Siria. Le accuse mosse nei confronti di Ankara relative al fatto che Erdogan a suo tempo avrebbe barattato Aleppo in cambio di una libertà di manovra nel nord della Siria potrebbero non essere del tutto fuorvianti. Occorre tuttavia effettuare alcune considerazioni di carattere politico-militare. Nel momento in cui la Turchia si è resa conto del fatto che stava combattendo un conflitto nel quale aveva sia Russia che Stati Uniti quali avversari mentre non poteva contare su alcun aiuto da parte degli alleati facenti parte dello storico “zoccolo duro” del gruppo degli “Amici della Siria”, Ankara ha dovuto cercare di accomodarsi con la Russia optando per un programma politico “minimale” ovvero tentare di fermare l’espansione dei Curdi nel nord dello stato siriano attraverso un’operazione militare che, contemporaneamente, da un lato salvasse una parte della ribellione anti-Assad e la propria credibilità internazionale e dall’altro ottenesse l’avallo sia di Mosca che di Washington. Da questo punto di vista la Turchia ha conseguito ciò che si prefiggeva di ottenere, pur dovendo abbandonare (almeno fino a pochi giorni fa) le sue più ambiziose mire geopolitiche in terra damascena, trovandosi di fatto costretta a convivere con la crescente presenza russo-americana nella Siria settentrionale occupata dai Curdi ed ad accettare, talvolta, la non sempre “leale” collaborazione militare di Mosca contro l’ISIS. Da questo punto di vista la Turchia forse ha dovuto scegliere se continuare a sostenere l’ormai impossibile difesa di Aleppo lasciando in città valide forze combattenti prossime alla distruzione o se spostare risorse verso territori maggiormente difendibili anche in funzione del problema relativo alle mire curde lungo il confine siro-turco. La Turchia fondamentalmente si è dovuta accordare con Russi ed Iraniani a fronte del fatto che la guerra in Siria ormai appariva del tutto compromessa per la ribellione anti-Assad e che pertanto la sconfitta di quest’ultima avrebbe trascinato Ankara fra coloro che avrebbero subito le conseguenze geopolitiche della catastrofe bellica siriana . Da parte dei Paesi del Golfo, tradizionali sostenitori dei ribelli anti-regime, negli ultimi mesi è apparentemente sceso il silenzio anche se la ripresa degli scontri presso il cosiddetto “fronte sud” farebbe pensare al fatto che il supporto dei Paesi arabi e dei loro alleati occidentali non sia del tutto svanito ma che anzi sia stato indirizzato in parte altrove rispetto al nord della Siria con lo scopo di far scendere la pressione di Russia ed alleati sui ribelli ubicati nella Siria settentrionale. I Paesi del Golfo (come Israele) hanno cercato di cavalcare l’onda delle pulsioni “persianofobiche” trumpiane, pur probabilmente dovendo riconoscere il fatto che la politica estera di Donald Trump non avesse sostanzialmente né capo né coda dal momento che Teheran è stretta alleata di Mosca e nessun accordo con Putin poteva nascere respingendo in toto l’accordo sul nucleare iraniano. Particolarmente critica è apparsa la posizione di Regno Unito e Francia i quali, dopo il progressivo allontanamento diplomatico degli Stati Uniti, si sono ritrovati sostanzialmente soli sullo scacchiere internazionale delle grandi potenze a supportare in qualche modo l’idea di una transizione politica in Siria. Da questo punto di vista gli ultimi mesi sono stati drammatici sia per Londra che per Parigi, non essendo stato affatto chiaro quanto l’amministrazione Trump fosse ancora propensa ad offrire il proprio supporto logistico e militare all’opposizione siriana e, come se ciò non bastasse, quanto fosse disposta a proseguire lungo la strada costituita dal pluridecennale percorso tracciato dall’Alleanza Atlantica. In particolare Londra teme da tempo che la Brexit possa consumarsi senza avere le spalle coperte dalla “relazione speciale” con Washington e parimenti Parigi, nonostante si sia profuso ogni sforzo per eliminare i candidati “pro Putin” all’Eliseo (e ciò contrariamente a quanto accaduto negli Usa nei confronti di Trump), si domanda che cosa rimarrà della politica estera francese se personaggi connotati da idee “filomoscovite” dovessero diventare il prossimo presidente della repubblica d’oltralpe. Oltretutto le crescenti ingerenze russe in Libia hanno ulteriormente aumentato il livello di allarme presso le cancellerie anglo-francesi, dato che il generale Haftar, grande escluso (e deluso) del governo di unità nazionale, si è recentemente pericolosamente avvicinato a Mosca in cambio di un sostegno politico e bellico. Il crescente rafforzamento sul piano militare dell’alleanza tra Assad, Hezbollah ed il Cremlino ha costituito una fonte di costante preoccupazione anche per Israele il quale ormai teme che l’Iran, tramite Hezbollah in Siria, possa giungere a minacciare direttamente l’esistenza dello stato ebraico, costringendo pertanto Tel Aviv ad intensificare, pur con risvolti sempre più drammatici, la propria azione militare in territorio damasceno. Se sullo scenario siriano Russia e Cina sono riuscite a paralizzare il consiglio di sicurezza dell’ONU bocciando sistematicamente tutte le principali risoluzioni promosse da Francia e Regno Unito, in estremo oriente la Corea del Nord, storico alleato di Pechino, è costantemente riuscita a tenere in scacco sia gli alleati regionali di Washington che gli Stati Uniti stessi e ciò si è primariamente verificato perché neppure l’amministrazione Trump si è dimostrata in grado di formulare una coerente condotta di politica estera e militare sia nei confronti della Cina che dei propri partner locali quali la Corea del Sud ed il Giappone. In questo caos sia Mosca che Pechino hanno tratto pieno vantaggio dalla situazione. In particolare la Cina ha potuto approfittare dell’ondata protezionistica dell’amministrazione Trump per attrarre le simpatie di quei Paesi che ancora credono nel libero commercio ed in una limitata applicazione dei dazi come le nazioni aderenti all’Unione Europea, le quali si sono presto trovate anch’esse nel mirino della “purga iconoclastica” della Casa Bianca. Parimenti l’Afghanistan non è stato immune all’interesse cinese e russo. In particolare, stando a fonti americane, Mosca starebbe addirittura supportando i talebani, ufficialmente in funzione anti-ISIS, al fine di proteggere le proprie frontiere meridionali dall’infiltrazione del terrorismo islamico ultra-radicale. Tuttavia, al di là della retorica della propaganda politica di Mosca, pare che il Cremlino si stia semplicemente adoperando sul territorio al fine “scalzare” gli Americani da un Paese nel quale l’armata rossa subì una cocente sconfitta negli anni ’80 del secolo scorso, in particolare a causa dell’imponente aiuto militare statunitense e saudita elargito ai mujahidin operanti nell’Afghanistan occupato dai Sovietici. Donald Trump: “Questa o quella per me pari sono” Il punto più basso dei rapporti tra Stati Uniti ed alleati euro-mediorientali si è probabilmente consumato quando fonti governative e diplomatiche americane hanno dichiarato a fine marzo un cambiamento di rotta radicale nella politica statunitense sul fronte siriano ovvero il fatto che l’allontanamento dal potere di Assad non fosse considerato più una priorità per l’amministrazione Trump. Nonostante da parte di Londra e Parigi si fosse ancora una volta rimarcato il fatto che Assad dovesse lasciare il potere dopo una transizione politica, questo ulteriore mutamento di “umore” della Casa Bianca deve aver indotto Mosca ed alleati ad intendere che Washington fosse ormai pronta per un accordo vantaggioso sulla Siria. Assad, dal canto suo, deve aver letto queste ultime dichiarazioni americane come la formale accettazione della sua permanenza in carica da parte di Washington e pertanto si è probabilmente sentito legittimato ad agire come meglio ritenesse opportuno. Quello che però né Assad né Putin immaginavano era che a Washington le condizioni per un colpo di mano contro Trump (e le sue tendenze familistiche) fossero ormai mature. Le inchieste volte a chiarire i rapporti tra i consiglieri del presidente ed i Russi probabilmente si erano progressivamente approfondite a sufficienza anche grazie all’aiuto di vecchia data dei Britannici e già alcune “teste” vicine al presidente erano saltate (Flynn, Bannon) in seno all’amministrazione americana proprio a causa di rapporti non leciti intercorsi con ambienti dei servizi segreti russi. L’attacco chimico di Assad contro la popolazione civile siriana ha rappresentato il “casus belli” per quello che non sembrerebbe esagerato definire come una sorta di “mini golpe” in seno alla Casa Bianca. Non si spiega altrimenti come sia stato possibile che il presidente Trump ed il suo gabinetto di ministri abbiano mutato di 180 gradi, nel giro di pochissime ore, l’orientamento politico insito in tutte le più importanti dichiarazioni offerte ai media mondiali in tema di politica estera da Trump stesso e dai suoi più stretti collaboratori. Si può supporre che nel momento in cui Assad, con il tacito consenso dei Russi (i quali, forse, in seno alle imperscrutabili logiche del Cremlino, preparavano la prevedibile vendetta per il fin troppo puntuale attentato alla metropolitana di San Pietroburgo), gasava cittadini siriani inermi, i militari e l’intelligence “a stelle e a strisce” abbiano posto sul tavolo del presidente prove inoppugnabili relative a rapporti intercorsi tra elementi del suo entourage (o addirittura lui stesso) e i servizi russi e abbiano costretto il presidente o ad affrontare con accondiscendenza il ricatto o a subire le gravi conseguenze derivanti dall’aver intrattenuto, direttamente o indirettamente, rapporti “non autorizzati” con Mosca. Trump, colta la rilevanza delle accuse mossegli e delle possibili conseguenze poste alla sua attenzione dal “fronte tradizionalista” del governo americano, ha evidentemente capito “l’antifona” e si è trovato costretto ad ufficializzare quello che gli è stato chiesto di fare, di fatto sconfessando totalmente l’intera linea politico-programmatica che la Casa Bianca aveva sostenuto in politica estera fino a pochi giorni prima, a partire dal più volte preannunciato nuovo corso nei rapporti con Putin fino alla palese dichiarazione di inutilità della Nato. Ciononostante la possibile assunzione di leadership da parte dei militari dell’amministrazione Trump non è stata organizzata a pieno svantaggio dell’immagine del presidente Usa, dato che Trump aveva sempre promesso all’elettorato di far tornare gli Stati Uniti all’apice della propria potenza militare. Lo stesso attentato di Stoccolma, occorso nel medesimo giorno dell’attacco americano in Siria, ha in un certo qual modo offerto un omaggio alle capacità divinatorie di un presidente che già si era lanciato in previsioni suffragate sul nulla in merito al livello di sicurezza della capitale svedese. L’attacco americano in Siria ed il plauso generale degli alleati L’attacco americano alla base siriana dalla quale sarebbe partito il bombardamento chimico promosso dal regime di Assad ha suscitato il plauso generale di tutti coloro che a vario titolo hanno sostenuto nel corso dei sei anni di guerra civile i ribelli anti-regime, nonché la viva approvazione degli alleati degli Usa in estremo oriente come Australia e Giappone, i quali confidano di ottenere una politica più muscolare (ma non dissennata) da parte di Washington nei confronti di Cina e Corea del Nord. In particolare la Turchia ha potuto beneficiare di una ragguardevole boccata di ossigeno per le proprie aspirazioni in politica estera, essendosi trovata ormai da troppo tempo con l’acqua alla gola sulla questione siriana. Ankara pertanto si è sentita sufficientemente forte per riaffermare con rinnovato slancio il fatto che Assad se ne debba andare nonostante Erdogan stesso avesse ben chiaro che non poteva permettersi uno scontro con la Russia, soprattutto nel corso della campagna elettorale del referendum sul presidenzialismo che ha riguardato in primo luogo il proprio destino politico alla guida del Paese. Sia il Regno Unito che la Francia, dopo aver subito un crescente isolamento sul piano internazionale, hanno salutato con estremo favore l’azione americana anche se, dietro le righe, non sono mancati dei dubbi, soprattutto da parte francese, sulla razionalità e sulle reali finalità dell’iniziativa “trumpiana”. L’attacco contro il regime di Assad, promosso dall’amministrazione americana, ha indubbiamente mandato un segnale a Damasco in tema di apparenti “linee rosse” che non dovrebbero essere superate e di accordi platealmente non rispettati (come quello palesemente disatteso sulla consegna dell’arsenale chimico patrocinato e confezionato per Obama dall’inaffidabile e “bifronte” Russia di Putin), tuttavia tale azione militare non ha certamente condotto ad un punto di svolta la guerra civile siriana, essendo stati gli Americani ben attenti a non colpire obiettivi di interesse russo. L’ambigua azione internazionale del nuovo segretario di stato Tillerson apparirebbe maggiormente finalizzata ad inviare segnali geopolitici ben precisi al Cremlino rispetto al nuovo corso americano piuttosto che a sostenere effettivamente un cambio di regime a Damasco. Sembrerebbe in realtà che gli Usa, a seguito dell’azione militare posta in essere in territorio siriano, abbiano voluto mandare un messaggio a Russia, Iran e Cina sul fatto che gli Stati Uniti, dopo gli anni dello smarrimento obamiano, siano tornati determinati a far valere le proprie irrinunciabili prerogative anche attraverso l’uso della forza. La bomba “Moab” in Afghanistan possiede indubbiamente un significato di questo tipo, soprattutto a fronte delle crescenti minacciose ingerenze sino-russe nella regione e dei relativi rovesci subiti dal governo filoamericano di Kabul. La vicenda nordcoreana va altresì letta nella logica dei rapporti commerciali in essere tra Stati Uniti e Cina. Lo stesso presidente Trump ha fatto capire che la guerra commerciale che la Casa Bianca intende intraprendere nei confronti di Pechino potrebbe essere calmierata dal fatto che la Cina risulti al fin fine “collaborativa” nel contrastare le mosse nucleari del regime di Pyongyang, storico alleato dell’ex-celeste impero e comoda spina nel fianco posta ai danni degli interessi americani. Ciononostante agli alleati europei e mediorientali, Israele inclusa, la “nuova” amministrazione Trump piace perché il potenziale militare offerto dall’alleanza con gli Stati Uniti potrebbe permettere loro di tornare a minacciare l’intervento americano qualora questi lo ritengano necessario per affermare i propri interessi. Tuttavia il fatto che i militari USA, dopo anni di umiliazioni subite nell’era Obama (il quale probabilmente non era facilmente ricattabile), siano riusciti a tenere in pugno la Casa Bianca come mai prima d’ora potrebbe risultare altresì pericoloso sia per coloro che ritengono di aver nuovamente ristabilito un canale di comunicazione privilegiato con Washington che per coloro che avevano sperato che l’isolazionismo trumpiano avrebbe alla fine trionfato, lasciando così totale campo libero a Mosca, Pechino ed alleati. Infatti se gli Stati Uniti ritengono oggi di dover riaffermare il proprio ruolo nel mondo iniziando semplicemente a far detonare armi convenzionali nei vari teatri globali di crisi, ciò potrebbe condurre ad un ulteriore imbarbarimento dei rapporti internazionali, ad una incontrollabilità ed imprevedibilità della politica Usa e a generare, in definitiva, delle conseguenze difficilmente immaginabili nel breve-medio periodo, in particolare a fronte di regimi, come quello nordcoreano, che alimentano il proprio potere interno anche grazie alle provocazioni militari messe in atto nei confronti dei presunti nemici esterni quali, per l’appunto, gli Stati Uniti. Un possibile nuovo test atomico della Corea del Nord potrebbe condurre ad un attacco aereo americano che a sua volta rischierebbe di indurre il regime di Pyongyang ad intraprendere azioni che renderebbero una guerra totale nella penisola coreana del tutto inevitabile. Parimenti questo stato di grazia nel quale i “tradizionalisti” americani si trovano ad operare da pochi giorni potrebbe comunque terminare se i “trumpisti” riuscissero nuovamente a riprendere in mano le redini della stanza dei bottoni. In questa situazione di incertezza e di estrema imprevedibilità le divisioni e le lotte interne insite da troppi anni in seno alla politica americana rischiano di non tramutare il mondo in un luogo più sicuro come molti sperano che torni ad essere lo scenario internazionale dopo la sorprendente conversione di Trump sulla via di Damasco. Purtroppo l’Europa rimane divisa sul da farsi ed in particolare sulla risposta da dare alla Russia in merito al suo coinvolgimento nella crisi siriana, essendo alcuni Paesi europei assai restii a sobbarcarsi la responsabilità e l’onere di tutelare in prima persona la credibilità politico-militare dell’Occidente (rimane in tal senso emblematico, oltre alla perdurante crisi ucraina, il tentato colpo di stato in Montenegro recentemente orchestrato da Mosca) se non, nei casi più estremi, come quello italiano, più interessati a fare affari con Mosca e a tramutarsi, alla bisogna, in volontari cavalli di Troia del Cremlino in seno alla UE in cambio di quale briciola russa in Europa orientale, in Siria ed addirittura nella nostra ex-colonia libica. Le derive autoritarie della Turchia di Erdogan hanno a più riprese adombrato le socialdemocrazie europee, ciononostante è arduo ammettere che si possa chiedere alla Turchia di contribuire alla stabilizzazione del Medioriente (fornendo, oltretutto, aiuto e supporto finanziario e politico) e pretendere contestualmente che questa tolleri in silenzio le critiche rivolte al suo governo in tema di diritti civili e democratici espresse con toni che lasciano pochi spazi all’interpretazione. Indubbiamente può suscitare una certa emozione negli animi più sensibili il fatto che in Turchia la democrazia possa essere, in un certo senso, messa in discussione, tuttavia la mera realpolik, la quale dovrebbe consigliare un’azione politica lucida e non scossa da un certo grado di dilettantismo, dovrebbe suggerire che, una volta cassata “de facto” ogni possibilità per Ankara di aderire all’Unione europea, non competa agli stati europei valutare pubblicamente se la Turchia si stia effettivamente avviando verso un presidenzialismo di carattere scarsamente liberal-democratico. Sarebbe invece maggiormente opportuno e nell’interesse di tutti gli attori in gioco che gli Europei si preoccupassero del fatto che una Turchia isolata e alla disperata ricerca di alleati non sia infine costretta a ridursi in una mera dépendance del Cremlino, mandando alle ortiche qualunque possibilità di plasmare a proprio vantaggio lo scenario siriano e mediorientale, nonché perdendo un’importante alleato politico e militare nella regione. Da questa prospettiva il recente insuccesso della missione diplomatica di Boris Johnson tesa a convincere i Paesi del G7 ad imporre nuove sanzioni a Mosca dimostra come una politica che non possieda alle sue spalle né un adeguato spiegamento di forze militari né alleati pronti a mettersi in gioco in prima persona poco possa fare per ingenerare un mutamento di idee sui grandi temi della politica internazionale in quegli stati che tutt’ora considerano la guerra come una mera continuazione della politica. In tal senso la battaglia “trumpista” atta ad indurre gli alleati Nato a spendere una cifra adeguata nel settore della difesa rimane probabilmente l’unico elemento ancora valevole e condivisibile dell’ormai apparentemente “tumulata” politica estera del “giovane ed inesperto” Donald Trump. [amazonjs asin=”B078GSSMX2″ locale=”IT” title=”Siria: Il perché di una guerra”] [amazonjs asin=”8899301190″ locale=”IT” title=”Siria: perché l’Occidente sbaglia? Saggio sul conflitto che insaguina il Medio Oriente”] ]]>
Pubblicazione gratuita di libera circolazione Gli Autori non sono soggetti a compensi per le loro opere Se per errore qualche testo o immagine fosse pubblicato in via inappropriata chiediamo agli Autori di segnalarci il fatto e provvederemo alla sua cancellazione dal sito Qualsiasi richiesta ingiustificata verrà considerata un abuso e potrà essere segnalata alle autorità competenti




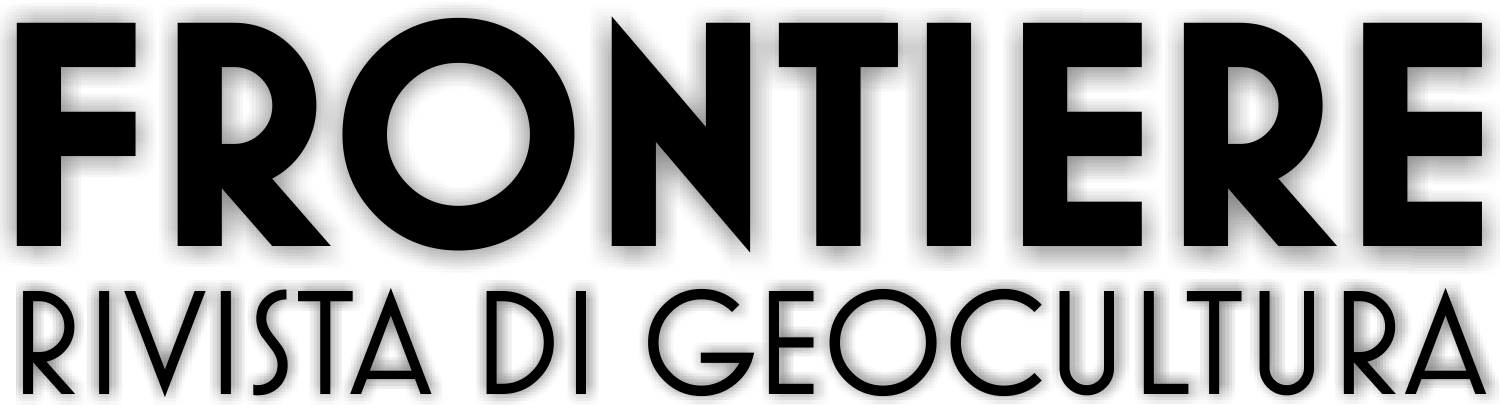

Buon’ giorno, c’e l’ha un traduzione dell “sulla via di Damasco,” per favore?